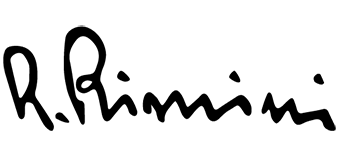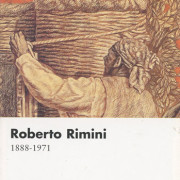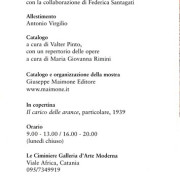Per Roberto Rimini di Giuseppe Giarrizzo
Non ho dubbi ormai, quando leggo nell’impegno di Roberto Rimini (Palermo 1888-Acitrezza 1971) la ricerca dell’anima ‘popolare’ della borghesia catanese: e mi chiedo, e chiedo all’esperto di linguaggi figurativi, se il linguaggio del pittore non risponda – e in che misura – a quella ricerca. Trovo comunque il tema interessante per almeno due ‘ragioni’: la differente percezione che la Sicilia catanese ha del ‘popolare’, differente rispetto alle tradizioni napoletana e palermitana (e regionali in genere); e l’opportunità che l’analisi di quella ricerca può offrire allo storico sociale di definire i tratti, per lo più controversi, della cultura ‘borghese’ del Novecento nella Sicilia orientale. Rimini era nato, è vero, a Palermo: ma Federico De Roberto, presentandone l’opera a metà degli anni ’20, di Rimini dirà che «a Catania fu portato bambino, di Catania apprese la parlata, a Catania cominciò i suoi studi, e qui tornò dopo averli compiuti, e qui vive e lavora ed espone e vuol morire …». Peraltro, questo approccio critico è maturato in me negli ultimi anni e si iscrive in una lettura della cultura e dei caratteri della borghesia catanese che trovo più convincente della lettura ‘salveminiana’ in cui mi ero fino agli anni ’80 riconosciuto. Ché, incontrando Rimini come documento, quando scrivevo a metà degli anni ’80 il mio libro su Catania, ne diedi nel contesto un giudizio severo: «Meno chiara [rispetto al décor urbano del centro] è – scrivevo allora (pp. 250-51) – l’influenza che la nuova ‘cultura dell’immagine’ ha sulle arti figurative a Catania: qui, a differenza che a Palermo, il futurismo era stato a cavallo della guerra una esperienza soprattutto letteraria; lento nella cultura figurativa, ancor più lento nel gusto era stato perciò il distacco dalla ‘maniera napoletana’ dei Di Bartolo, dei Reina, dei Gandolfo. Ma negli anni Venti la fotografia d’arte aveva avuto facile ragione del provinciale naturalismo impressionista, che era ancora nella Catania di Carnazza lo “stile dei giovani”»: e qui, associando Rimini al più giovane M.M. Lazzaro (1905-1968), e del primo prendendo per buona una non felice definizione (1935) di Raffaele Leone, ne rovesciavo la storia in una speculare comprensione dell’eclettismo impaziente di Lazzaro. E il riconoscer in Lazzaro un’urgenza autentica sua di svecchiamento, «la febbre di svellersi dalle strettoie […] delle convenzionali vedute», sospingeva Rimini ‘o della serenità’ a farvi la parte del vecchio, e nel linguaggio e nei temi.
Leggi tutto
Avevo allora trascurato il distacco generazionale, quando non collocavo Rimini in quella ‘generazione della guerra’ cui appartenevano – sol di pochi anni suoi maggiori – Adolfo Omdeo e Luigi Russo. «Avevo divisato di restare ad operare a Venezia dopo la conclusione dei miei studi [alla scuola di Ettore Tito], ma la guerra 1915-18 mandò in aria i miei piani. Fui combattente dall’inizio e mi congedai alla fine da tenente del 1° Genio zappatori». Ora a Catania, come in tutto il Mezzogiorno, la Grande guerra non portò solo fratture; ed accelerò piuttosto processi di crescita socio-culturali, maturati a cavallo del secolo nella società e nella cultura cittadine. Nel 1920, l’anno ‘verghiano’ per le celebrazioni degli 80 anni del grande scrittore, scompaiono Giuseppe De Felice e Nino Martoglio, due figure-simbolo della Catania popolare, che era stato lo spazio fisico e ideale delle loro ‘invenzioni’, il popolarismo della Milano del Sud e la geniale rivendicazione della dialettalità urbana nei tipi e nel linguaggio. Catania popolare certo, cui la guerra avrebbe aggiunto acri umori ed attese: ma era la ‘città borghese’ a consumare in quel tempo, a cavallo della guerra, il suo trionfo sociale, quando si toccano le punte alte dell’immigrazione borghese dalla provincia e Catania si esalta nel ruolo che le è proprio di capitale. Giacché la ‘provincia’ non è solo il vasto hinterland del catanese e dell’ennese (Enna dovrà aspettare il ’36 per costituirsi in provincia), ma nella loro lenta, strutturale pendolarità si sono consolidati i flussi ‘borghesi’ dalle provincie di Ragusa e di Siracusa – per l’ormai secolare attrazione dell’Università, dei tribunali, degli ospedali cui fa capo la consistente borghesia delle professioni.
Tutti gli studi professionali (avvocati, medici, ingegneri e architetti) di quella vastissima ‘provincia’ hanno a Catania i loro referenti, territorialmente disposti nelle vicinanze dei luoghi deputati alle rispettive attività: e questi ultimi sono non di rado membri della famiglia allargata o di consorterie disposte attorno ad un nucleo familiare e familista. E vi s’aggiungono in provincia i corrispondenti delle agenzie marittime, che trattano di merci e di uomini – giacché l’emigrazione, nonostante il blocco statunitense e il filtro fascista dei tardi anni ’20, conosce modifiche e non certo l’arresto dei flussi. Così la Catania post-bellica degli anni ’20 è culturalmente borghese, di una borghesia dinamica ed aperta, che si alimenta di un altrettanto tradizionale fermentare dell’artigianato e del commercio – da cui vengono, accanto all’immigrazione provinciale, i nuclei borghesi di origine cittadina. Rimini si ‘legge’ nella generazione della «Rivista del Comune»: Villaroel, Cardile, Scalia, Prestinenza, Caioli, Manzella Frontini e su tutti Enzo Maganuco – una generazione per la quale la figura simbolo resta Federico De Roberto. Resta un fatto, nel riferimento a Maganuco ed a Francesco Pastura, l’insistenza – nel ricordo di Rimini – del loro interesse per il ‘popolare’, fosse canto o disegno. Che son poi i protagonisti di una incerta ‘catanesità’, tutta centrata nel mito e nel culto di S. Agata, cui i nuovi venuti si eran venuti omologando anche se non rinunciano (si vedano i nomi familiari) ai culti e alle devozioni di origine.
Si aggiunga una tradizione carsica, che ha visto nel Settecento emergere i maggiori architetti dalle folte maestranze, e gli artisti dall’artigianato – se vogliamo capire con la parabola di Rimini quella affine di Emilio Greco, da marmoraro a scultore. Sono le decorazioni tipizzate dei soffitti, con gli ovali e le sopraporte: per Rimini, come per altri artisti siciliani della generazione, lo apprendistato continentale che in quegli anni era invitato a riscoprire col maestro gli stilemi regionali o locali avrebbe lasciato segni evidenti nella tecnica e nel linguaggio, ma al ritorno in Sicilia rendeva obbligata l’attenzione per quel che distingueva i localismi d’origine dai localismi di cui si era fatta altrove esperienza e conoscenza. A Catania e nel catanese peraltro, or che tacevano Verga e Capuana (e Rapisardi vivo nel ricordo polemico del popolo), era vivo – accanto all’ultimo e tormentato De Roberto – il teatro ‘folclorico’ di Giovanni Grasso e (presto) di Angelo Musco. E fu questa Catania ‘borghese’, che aveva appreso a depositare nel popolo le virtù di una nobiltà divisa.
Città socialmente, culturalmente ‘borghese’, la Catania in cui Rimini è sollecitato a recuperare la sua Sicilia – se quel che resta dell’aristocrazia maggiore (i Biscari, i Carcaci, i Moncada, i Reburdone, ecc.) ha ormai, per un differente percorso politico e culturale rispetto all’aristocrazia di Palermo, modi di vita, abiti, consumi e modelli borghesi di sociabilità. Da tempo l’artigianato ‘alto’ – sarti, orefici, mobilieri – serve nobiltà e ricca borghesia, e agevola gli scambi culturali imposti dalle rispettive strategie familiari mentre trae vantaggi innegabili dall’ampliarsi e dall’omologarsi delle committenze. Capitale, Catania è un grande mercato di consumo, della stessa città e della provincia: ed è un mercato tanto vasto a dar conto di una vivace attività di produzione culturale – che riguarda l’edilizia e l’arredo, la letteratura e il giornalismo, le dimensioni tecniche e sociali della scienza medica e del diritto. L’editoria conosce negli anni ’30 la fase terminale di un’egemonia territoriale che ha visto quasi tutti i librai catanesi farsi a vario titolo editori.
Se questa è la chiave culturale, Rimini non è solo un documento degli anni Trenta: lo diventa se in lui si riesce a cogliere, come tentò Enzo Maganuco, la persistenza di una sottile capacità evocatrice, come un veder doppio ma su strati sovrapposti di vario spessore: il desiderio e l’impegno che il mestiere non riduce a sigla di sentire e rappresentare gli ‘affioramenti’ ora nella figura ora negli ambienti. Qualcuno ha ricordato opportunamente le radici venete ed ebraiche della famiglia: lo so, questo del fondo etnico, è un motivo tanto difficile a maneggiare da consigliar spesso la rinuncia. E non l’avrei ricordato se non potessi invocarlo a correttivo di letture banali, e non mi sentissi inquietato dal rapporto di Rimini con la luce che non è mai diafana ma ‘esplosiva’ come dopo avere vinto una resistenza o spinto in avanti il muro dell’ombra. La ‘serenità’ non è un’arcadia sognata, è invece una momentanea conquista, una ‘quiete’ costantemente insidiata.
È un percorso che ha reso Rimini, forse più nel colore che nel disegno, l’interprete di un profilo dinamico della Catania borghese, borghese e provinciale. Guardate le case: il cuore degli interni sono, al piano nobile, il salone ed il salotto, per le danze e le feste l’uno, l’altro per i concerti da camera, le recite amatoriali, le letture. Ma non è solo lo spazio a conferire identità a quei luoghi: è l’arredo e la decorazione di mura e soffitti. Chi si trovi a visitare di queste case alto-borghesi il molto che è ancora visibile è colpito dalla dignità dei linguaggi figurativi, che la memoria (o il documento) consente di ricondurre a figure minori di cui soltanto una storia sociale delle arti del nostro Novecento potrà dar conto (ma restano ancora frammentari i dati, e inadeguata la riflessione critica). Ora la borghesia di Catania non può nella città disporre di spazi ampi e decorati come quelli del piano nobile del palazzo aristocratico: il loro costo era spesso superiore ai redditi che provenivano da investimenti borghesi in terre o in rendite. Ma gli architetti erano spesso chiamati a duplicare in provincia un progetto cittadino: e qui salone e salotto importavano dalle botteghe e dai negozi della capitale le tipologie di arredo e persino di colore.
Con la decorazione la musica, da teatro o da salotto, aveva costituito a cavallo del secolo lo spazio in cui si colgono tratti forti del costume borghese internazionale: qui forse maggiore attenzione è stata data al consumo di musica e di pittura che precede – come nel rapporto tra cinema e teatro – il tempo della registrazione in disco, o del fumetto. Ancora nei tardi anni ’30 era consuetudine della borghesia catanese (nell’accezione di capitale+provincia, in cui qui lo impiego) ‘educare’ in casa le ragazze da marito: e di questa educazione eran parti la lettura ed esecuzione della musica per piano, la conoscenza del francese, il disegno. La musica voleva essere al tempo stesso, motivi e testi, un fattore di educazione sentimentale e non solo un carattere della sociabilità borghese: vi contribuiva, in provincia, la frenesia che già prima della guerra aveva preso le Amministrazioni locali per il ‘teatro comunale’, che accoglieva compagnie teatrali di giro, ma anche compagnie di musica e di operette di tema or comico or sentimentale. E la fotografia spingeva ancora alla posa ‘borghese’, e vi costringeva il ritratto pittorico che le imponeva stili e atteggiamenti. E se dopo il Concordato del ’29 si assiste anche a Catania ad una ripresa pilotata di musica sacra, e di ‘restauro’ delle chiese ridecorate: questi recuperati spazi tradizionali di sociabilità sono anche luoghi attraverso cui passa la ‘popolarizzazione’ della musica alta, di personaggi della tradizione teatrale, di scene ‘a simbolo’.
La svolta sarà tuttavia segnata dalla radio, e dal ruolo che il regime le assegna nell’acculturazione politica delle masse, e nelle diffuse attività dopolavoristiche. Ed è l’immaginario che la radio sommuove a portar fuori dal futurismo: la pittura, in genere tutte le arti visive accettano la sfida della modernità. Non v’ha confronto con i processi localizzati di un’embrionale ‘cultura di massa’: la modernità del fascismo, su cui si aprono e si chiudono frequenti contese, si esprimeva attraverso la diffusione dei linguaggi non verbali che agevolavano, con le immagini ed i suoni, i messaggi verbali del regime. Si è passati così anche a Catania dalla ‘popolarizzazione’ della cultura alla ‘cultura di massa’. E nella cultura di massa, che accede alla radio e al disco, e che vien dominata dalle grandi campiture pittoriche, sono recuperati con vario successo elementi del repertorio borghese, quello di fine secolo e quello degli anni ’20 e ’30: la musica è, dalla romanza alla canzone, un veicolo importante del patrimonio del popolo che non ha più discriminanti ‘classiste’; ed è docile ai processi di omologazione che vogliono essere di perequazione sociale del regime.
II cambiamento peraltro riguarda anche la città-capitale, che in questi decenni si modifica profondamente, né solo nell’immagine: alla ‘borghesia’ delle professioni e dei servizi si aggrega una borghesia degli apparati, amministrativi e/o assistenziali, che però non assume più a modello il continuum nobiltà-borghesia quale era uscito vincente dalla crisi della guerra: si era già dentro una contemporaneità, che avrebbe caratterizzato la vita e la cultura di Catania fino agli anni ’70. Già si attenuavano negli anni ’30 i ruoli dell’artigianato ‘alto’ della capitale: e la provincia guadagnava autonomia nei servizi, con una forte caduta nella qualità e per il minor costo dei prodotti (fossero di mobilieri, di sarti, di apparatori, di decoratori) una estensione dei consumi medi. Mentre cedevano, di fronte alla politica nazionale, l’editoria e la pubblicistica. Sempre meno frequente era la nostalgia dell’Ottocento, e l’orgoglio per i luoghi dell’identità si attenua nel confronto che foto e rotocalchi danno dei simboli nazionali della ‘grandezza’.
Ciò spiega l’eclisse nel secondo Dopoguerra dei valori e dei motivi della ‘grande Catania’ di cui Brancati e Patti celebreranno con stili diversi la fine reale e la virtualità del ricordo. Rimini era un uomo d’altra generazione, e il suo mondo rimase quello da lui ‘riscoperto’ negli anni Venti: la tragica generazione degli anni Trenta non lo avrebbe compreso. E, al pari della musica ‘borghese’, la sua pittura galleggia, come un fiore finto da vecchia oleografia, su un flusso discontinuo di memorie, un vezzo agghindato che pochi sanno leggere. E la storia degli storici non sempre soccorre a far quella lettura al tempo stesso partecipe e intelligente.


«Sembra che Rimini abbia avuto l’incarico di illuminare i quadri degli altri» di Valter Pinto
Sulla tela bianca grumi di colore si dispongono secondo un ordine solo al primo sguardo casuale (tav. CI). La pennellata non è continua, nella sua frammentazione lascia spazio al bianco del supporto che, colore, s’integra e dialoga con i pochi tocchi già presenti: rossi ruggine e arancio, blu, gialli e verdi acidi, del nero. Il dipinto è incompiuto, è restato così sul cavalletto e, perché non terminato, non può assurgere ad esemplificazione della ricerca artistica di Roberto Rimini, neanche di quell’estrema degli ultimissimi anni Sessanta. La prima impressione informale, man mano che la retina registra ad uno ad uno i percorsi del pennello, deve cedere il passo al riconoscimento della figurazione: non di un astratto otto coricato si tratta ma di un tema più consono al pittore: il Trasporto delle reti. Istruito dal ricordo di una vicenda artistica coerente, l’occhio può ora facilmente riconoscere non solo due uomini di spalle, all’estrema sinistra e al centro del campo figurato, ma anche, nella confusa coda in basso sulla destra, un abbozzo di gamba di un terzo personaggio ancora, allo stato, annegato nel gorgo della rete da pesca che trasporta.
Leggi tutto
Un modelletto di qualche tempo prima chiarisce, se ancora fosse necessario, l’intenzione del pittore (tav. XCIX). Un pezzo squisitamente figurativo, una tranche de vie di quelle più care a Rimini nel corso della sua lunga carriera: uomini, e altrove donne, fermati nei loro gesti quotidiani, nel loro mestiere di vivere, nella celebrazione sacra della fatica quotidiana. E tuttavia il confronto fra il disegno e il dipinto incompiuto ci permette di accedere ad altro, una volta che si sia abbandonata la sempre tranquillizzante analisi del contenuto, ci permette di cogliere i modi della realizzazione, il linguaggio specifico del pittore. Per quanto compiuto, tanto da essere certificato dalla firma, il disegno mantiene la sua vitalità di studio, ma studio di luce non di composizione. Il pittore è infatti alle prese non con la cattura dal modello, dalla evidenza naturale, delle forme, delle anatomie, delle disposizioni nello spazio – tutte cose queste ben metabolizzate e ormai naturalmente attingibili dal bagaglio delle lunghe e, s’immagina, quotidiane osservazioni, tanto da non mostrare nella messa su carta alcun’incertezza – il pittore ha bisogno di fissare e studiare le ombre, di costruire lo spazio non con la linea ma con i contrasti. Avaro di linee di contorno, non esita a lasciare ampie campiture senza segno e rinterzare con forza altri passaggi. Anche quando tornerebbe utile colmare con la matita il brano – le braghe e il cappello del pescatore di sinistra ad esempio – si astiene dal farlo: sa che in natura il nero-nero, il rosso-rosso, non esistono, sa che basta una lieve increspatura di un panno, una ruga di un volto, a determinare una diversa reazione alla luce, ad affondare con un’ombra un nero, a riflettere in chiaro un grigio.
Catturare la luce: è questa la sfida, ancora adesso che le forze diminuiscono, che ottantenne si avvicina, attraverso la consueta artigiana tappa del modelletto, al dipinto. E così allora, anche se incompiuto, il Trasporto delle reti ben si presta ad offrirsi come chiave per entrare nell’universo artistico di Roberto Rimini. Ci offre un privilegio che certo il pittore non ci avrebbe facilmente concesso e, non senza superare l’imbarazzo di chi voyeuristicamente entra in una stanza nella quale non era stato invitato, ci ritroviamo nell’officina, nella bottega, nell’atelier dell’artefice.
Ma, per non correre il rischio di trovarsi impreparati, è bene dapprima ripercorrere i mo menti salienti di una lunga ed operosa carriera. Siamo facilitati a farlo grazie al saggio di repertorio delle opere che, in questo stesso volume, è stato allestito dalle amorose e sapienti cure della nipote, Maria Giovanna Rimini. Un catalogo che assomma oltre trecento numeri e che ambisce alla completezza nella coscienza di non poterla raggiungere: tante sono, infatti, le opere di cui si è persa la traccia una volta che, accaparrate da amatori di passaggio per la Sicilia orientale, hanno lasciato l’isola. Si può così agevolmente passare dall’ultimissimo dipinto agli esordi, ai primi passi figurativi del mancato studente tecnico che ha spiccato il gran salto e ha seguito la propria vocazione pittorica. Ma è bene che l’ideale carrello che precipitosamente va all’indietro si fermi prima di trovare il fondo.
1914. Nel secondo numero della rivista «Rassegna Siciliana», che reca la data 1 giugno, è pubblicata una riproduzione di un dipinto di Rimini, un Autoritratto (tav. II). Il ventiseienne artista si effigia nella classica posa del ritratto di tre quarti, quasi di spalla; il busto celato da un ampio mantello ravvolto fin quasi a nascondere anche il collo; gli occhi ben fissi a cercare il fruitore; il volto, in asse con il busto, stagliato contro un disco formato da cerchi concentrici che, nella parte lasciata in evidenza dal viso, riflettono metallicamente la luce. E con questo si esaurisce quanto c’è da dire sugli aspetti disegnativi, di composizione, dell’opera poiché, per quanto costretti nell’analisi ad affidarci alla trascrizione fotografica, in mancanza del dipinto originale non più reperibile, subito dobbiamo riconoscere che già in questa fase giovanile il pittore non sembra dedicare più di tanto alla ricerca della posa e s’impegna a cesellare l’immagine con studiati orli di luce: la canna del naso in ombra trova la sua strada fra le coppie di luce-ombra, bianco-nero, formate dalle prominenti arcate orbitali e dalle sopracciglia per risolversi nel triangolo luminoso dell’importante narice in vista; il risvolto del mantello, cadente verso il petto e orlato da una pennellata di luce ed il suo corrispettivo nell’altra pennellata luminosa che, lungo il collo, scende dal lobo dell’orecchio; e si potrebbe continuare.
Si può provare, inoltre, ad integrare il referto fotografico, che abolisce il colore e semplifica il ductus pittorico, con un dipinto dello stesso anno, il Ritratto di Carmelo Politini (fig. 5). Il rosa dell’incarnato del volto accoglie naturalmente il grigio verde dell’ombra, vi si giustappone nella fronte, negli zigomi; le orbite s’illuminano dell’acquosità dello sguardo che si intensifica proprio grazie a questa sua liquidità; per quanto in posa silente e con gli occhi ben fissi il personaggio sembra colto in un’istantanea che ferma il movimento in atto. Non ostante l’ufficialità della posa, grazie alla sprezzatura della pennellata fresca, veloce, il pittore può vitalizzare il ritratto e non indulgere nel disegno del nodo della cravatta e solo accennare il taglio della giacca che appena si stacca dal fondo, poco di più di un tono più chiaro.
Provandosi a mettere idealmente accanto l’Autoritratto e il Ritratto di Carmelo Politini emerge però anche una distonia: per quanto dello stesso periodo e pur nell’unità di fondo delle intenzioni artistiche, è indubbio che abbiano diverse ambizioni. Per provare a capire non si può, in questa fase, eludere un cenno al modo in cui l’artista sta cercando il suo stile e per farlo è necessario riassumerne la formazione. Si può partire da quanto lo stesso Rimini sintetizza in un manoscritto di appunti per una propria autobiografia, messomi a disposizione dalla famiglia: «Della prima età mi piace ricordare i giuochi estivi alla Barriera del Bosco in compagnia del caro Pippo De Logu … nelle pause … riecheggiavano i fantasmagorici discorsi di Pippo mentre io riempivo un vecchio cartone d’inverosimili sciancati con delle mostruose stampelle. È strano, iniziavo col cerebralismo, bandito poi quasi per sempre. Proprio in quelle giornate cominciai a considerare seriamente la pittura ed a ciò influirono sicuramente il calore e l’amore che Pippo metteva nei suoi discorsi». È indubbio che nell’Autoritratto emerge proprio quel «cerebralismo» che, a distanza di tempo, il pittore, sapendo di non averlo poi perseguito, schiaccia in una dimensione quasi infantile, precedente lo stesso apprendistato. Cerebralismo, vale a dire, certo, intellettualismo ma soprattutto, in questa sede, rappresentazione non diretta della realtà, capacità di vedere ciò che il non artista non vede, trasfigurazione del dato fenomenico in forma simbolica, creazione o, meglio, dar vita ai mostri dei sogni.
Si riveda allora l’Autoritratto e si ricordi quello che, potenza delle casualità, nello stesso giro di anni, a distanza di migliaia di chilometri, Majakovskij declamava: «Non c’è nel mio animo un solo capello canuto, / e nemmeno senile tenerezza! / Intronando l’universo con la possanza della mia voce, / cammino – bello, / ventiduenne», proseguendo «Ehi! / Signori! / Dilettanti / di sacrilegi, / di delitti, / di massacri, / avete visto mai / ciò che è più terribile: / il viso mio / quando / io / sono assolutamente tranquillo?». Il poema da cui sono tratti questi versi è del 1914-1915 ed è noto con il titolo di «La nuvola in calzoni» imposto dalla censura zarista ma, ulteriore suggestione, il titolo originario era «Il tredicesimo apostolo»: come altro si potrebbe interpretare il disco su cui si staglia il volto del pittore se non in una aureola?
Lasciate libere le fascinose briglie dell’evocazione, è il caso però di raffrenarsi ed attenersi a più certe considerazioni sui dati di fatto. Alla vigilia dell’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale, nella quale egli stesso sarà coinvolto, Rimini è un artista formato che può coniugare insieme pittura ambiziosamente cerebrale e apparentemente, più rassicurantemente, decorativa.
Il ricordo di Rimini prosegue: «Superate brevi lotte familiari, interruppi gli studi tecnici e andai a Venezia per frequentare l’Accademia di belle arti. Ettore Tito fu il mio grande maestro». Dove è notevole che il pittore sottace un soggiorno di due anni a Napoli, tra il 1905 e il 1907, dove avrebbe fatto a tempo a incrociare l’insegnamento dell’ormai ottantenne scultore Stanislao Lista (1824-1908). In ogni caso è a Venezia e a Tito che Rimini riconduce la sua educazione artistica.
Tito (1859-1941), anch’egli meridionale, formatosi a Napoli e poi trasferitosi a Venezia dove studia all’Accademia con Pompeo Molmenti, al quale nel 1895 subentrerà nella cattedra di figura che terrà fino al 1927, conoscerà la sua stagione migliore a cavallo dei due secoli fino alla grande guerra. In questo periodo avrebbe trovato maturazione il suo peculiare linguaggio artistico che, partendo dal gusto aneddotico-popolare di ascendenza favrettiana ma virato nel chiaro della gamma cromatica e realizzato con pennellate larghe e decise, brevi e taglienti, ricerca effetti di dinamismo, di istantanee fuggevolezze, di cangiantismo delle vesti, soprattutto femminili, realizzati con colori brillanti e briosi, preziosi. Elettosi erede dei fasti della grande pittura veneta del Cinquecento e, ancor più, del Settecento, Tito arriverà negli anni Trenta a idealmente competere con Tiepolo, quando si impegnerà in grandi affreschi – in un caso addirittura nello stesso luogo di un perduto, nel 1915, dipinto di Tiepolo nella chiesa degli Scalzi a Venezia – un confronto i cui esiti e intenzioni sono efficacemente riassunti da Roberto Longhi nel 1952: «sui mantelloni azzurri del Tiepolo [possono] scorgersi, a occhio nudo, salire in fila indiana le blatte di Barabino, di Bianchi, di Morelli, di Maccari, di Favretto, di Tito e sorvolare, basse, le mosche cocchiere dei Molmenti, Ricci, Oietti e cioè il punctum dolens della critica ufficiosa negli ultimi cinquant’anni». Il severo giudizio longhiano non impedisce di apprezzare nell’arte del giovane Rimini la capacità di suggere il meglio dell’insegnamento di Tito lievitato certamente dal confronto con le altre fonti di ispirazione cui poteva accedere a Venezia o a Roma, dove pure risulta per un anno fra il 1913 e il 1914.
Rimini dichiara che avrebbe eletto Venezia sua città d’adozione «ma la guerra 1915-1918 mandò in aria i miei piani». Le sue abilità artistiche sono sfruttate dall’esercito italiano, dal quale si congeda al termine del conflitto con il grado di capitano, che si avvale dei suoi «schizzi panoramici», eseguiti anche attraverso «ascensioni su palloni frenati», delle zone di operazione nel Carso. Esaurita la parentesi militare, Rimini ritorna stavolta definitivamente in Sicilia. Alcuni dipinti dello scorcio del secondo decennio – Alberi (verde e oro), Frutteto, In campagna (figg. 12-14), tutti purtroppo assenti dalla mostra per indisponibilità dei proprietari – ben testimoniano il punto di stile di Rimini: paesaggi certo, ma individuati come cortine di colore, macchie di luce, che non consentono allo sguardo alcun cedimento romantico alle infinità delle lontananze, quel taglio che ancora in Salice e Pesco (tav. VI) del 1914 accompagnava lo sguardo dello spettatore verso lo sky-line della città sullo sfondo è assente. Immediatamente dopo la guerra nei paesaggi di Rimini il cielo non trova spazio fra le foglie verdi e gialle, ma anche blu, dei suoi alberi. Se da Tito aveva appreso cosa significasse la pittura en plein air, come pure si è sostenuto, è certo che da quell’insegnamento, in questo momento, Rimini non trae partito. Del resto, subito prima della guerra, fra la Venezia delle mostre della Fondazione Bevilacqua La Masa a Ca’ Pesaro e la Roma delle mostre della Secessione, non dovevano essere mancati al giovane studente di pittura Rimini occasioni per accedere ad esempi che rimescolavano le carte del tranquillo tran-tran accademico e proponevano antiufficiali contaminazioni di generi e modi diversi. «Ricordare che un quadro, prima d’essere un cavallo da battaglia, una donna nuda o un qualsivoglia aneddoto, è essenzialmente una superficie piana coperta da colori messi insieme in un determinato ordine»: la celebre formula di Maurice Denis non poteva essere ignota a Rimini. Tanto più che se si cerca un punto di raccordo nelle prove pittoriche del secondo decennio di Rimini con esperienze coeve di suoi coetanei in Italia più che verso Venezia si deve puntare verso quelle esperienze, «in margine», che fra Roma e Napoli andavano conducendo Edgardo Curcio e Edoardo Pansini, Gennaro Villani e Eugenio Viti, vale a dire quegli artisti che, insieme ad altri, danno vita alla cosiddetta Secessione dei ventitré e animano una serie di esposizioni napoletane dal 1909.
È quella descritta fin ora una breve stagione nell’arte di Rimini, e con esiti di grande qualità – Terrazza e La pergola del 1922; L’abbraccio del 1926 (tavv. V; VII; XIII) –, che dovette costituire il nerbo della sua prima mostra personale del 1924 e poi di quella al palazzo comunale di Catania del 1927, per il cui catalogo scrisse la presentazione l’anziano Federico De Roberto. Lo stesso Rimini avrebbe poi retrospettivamente non solo ricordato come unitaria la produzione dalla fine del primo conflitto alla mostra del 1927, ma anche testimoniato dell’interesse di «Stefano Bottari il quale mi consigliava sempre di raccogliere i dipinti di quel periodo che avrebbero costituito ottimo materiale per una mostra antologica».
Nell’estate del 1927 Rimini si trasferisce a Taormina: quello che doveva essere un breve soggiorno si trasforma in una stabile dimora per ben otto anni. Così l’amico Enrico Cardile, giornalista e scrittore che, allontanatosi dalle giovanili esperienze prima simboliste e poi futuriste, era approdato ad un neo-idealismo di marca gentiliana e venato di misticismo, mentre stava per mandare alle stampe il suo L’Umanesimo come fondamento spirituale del genio italiano, 1929, avrebbe raccontato ai lettori de «L’ora» nel 1928: «Come tutti i veri creatori d’arte, giunti a certa epoca della propria esistenza, cercano rifugio nella solitudine, onde, in cospetto della natura, eterna e meravigliosa genetrice, sentirsi quasi purificare e rinnovare dalla consuetudine delle cose fresche e genuine della vita primitiva, così anche Roberto Rimini, pittore, dopo le vorticose vicende di Venezia e di altri centri maggiori, ha trovato sosta a Taormina, plaga di sogno e di bellezza. In questo eremo, in cui sembra che tutte le forze naturali esterne debbano concorrere a produrre il miracoloso fenomeno creatore interno, Roberto Rimini lavora da circa un anno, dando all’arte nazionale, lavori di potente originalità e di eccezionale buon gusto. I rari amici che vengono qui a raggiungerlo, passando con lui brevi ore affettuose d’intima ospitalità, tornano paghi dei minuti di mistica fervorosa esaltazione prodotta dalla simpatica compagnia di questo artefice. Il viaggio, poi, tra le sue tele e le sue idee, è un viaggio meraviglioso, che assume, per chi è capace di compierlo un fascino duraturo, anche oltre le brevi visite ed i brevi colloqui. S’intende subito che si ha da fare con un artista maturo, con un artista, cioè, il quale ha ormai una netta visione propria della cosa d’arte, ed una sicura padronanza della tecnica; un artista insomma il quale, conscio per cultura della magnifica tradizione e discendenza, affinato ormai da laboriose esperienze e dolorose vigilie, non ha più bisogno di correre brancolando dietro incerti e vacui tentativi per raggiungere la propria forma o concretizzare, in espresso d’arte, il proprio pensiero».
La lunga citazione credo renda bene la trita sovrastruttura ideologica dello scrittore, l’abuso dei tropi dai quali pur tuttavia emergono interessanti dati di fatto: intanto, l’appartarsi di Rimini sullo scorcio degli anni Venti e poi, sappiamo, per buona parte degli anni Trenta a Taormina, certo meta di un turismo cosmopolita, ma non centro dell’amministrazione e della politica come Catania. Un defilarsi forse meno netto di quanto lo stesso Rimini avvalorerà nei propri appunti autobiografici, del quale tuttavia non poche tracce, come vedremo, si possono rintracciare nella produzione di quegli anni. È però il caso di leggere qualche altro passo dell’articolo di Cardile: «Così, se a Roberto Rimini chiedete, quale tra le scuole d’arte, attuali e antiche, egli prediliga; quale dovrebbe essere il modo espressivo del grande artista, e quale l’essenza della vera arte, egli si limiterà a tentennare il capo, probabilmente senza rispondere» – e sarebbe forte la tentazione di richiamare alla memoria la risposta che il «divino» Michelangelo diede alle domande del «chierico» Benedetto Varchi di «lasciar tante dispute che vi va più tempo ch’a far le figure», se non si fosse frenati dall’indecisione sull’attribuire l’adesione al topos a Rimini o a Cardile –. Il quale prosegue: «Scatterà, soltanto, quando gli farete cenno di certa barbarie nuova, convalidata dalla critica d’occasione: della profanazione del sacrario d’arte; dell’arrivismo più sfacciato, della turlupinatura più bassa, ai danni del pubblico grosso di buona fede … Oggi, in arte e in letteratura, da qualcuno si compiono le più assurde e grottesche contraffazioni: peggio che al tempo del vero e proprio futurismo, nel quale erano, almeno, compresi indiscutibili valori, e si metteva in evidenza l’assoluto spirito di sincerità rompiscatole; oggi ancora un’accolta di gente diversa che in nome dell’arte tenta di avvalorare tutti i più ignobili documenti di un rachitismo cerebrale congenito, ha saputo accaparrarsi una specie di monopolio reclamistico e vendereccio: così in arte come in letteratura». Un passo questo dove di nuovo, pur andando solo sullo sfondo Rimini e la sua arte e prevalendo invece le astrazioni neo-idealistiche di Cardile, emerge il senso dell’appartarsi come disagio, come difficoltà a riconoscersi nelle prepotenti mode culturali. Cardile continua toccando quello che effettivamente è, l’abbiamo già anticipato, il nodo centrale nella produzione di Rimini: «Ed egli crede, essenzialmente, che il problema pittorico si riassuma, in fondo, in un problema di luce. Infatti le sue frasi più frequenti si riferiscono a tale problema: “Com’è resa questa luce?” “Ah! Potessi rendere tutta questa luce!”. Spesso ha pure dichiarato: “A Taormina c’è troppa luce: qui il problema si complica. La luce di Taormina non è quella degli altri posti del mondo: fa smarrire, abbacina”». Ma nella rinomata cittadina del turismo internazionale non solo questo problema artistico avrebbe incontrato Rimini: «Peraltro, appena giunto, e piantato lo studio sulle pendici del Monte Tauro, i soliti esperienti gli hanno consigliato: “Adattatevi ai gusti del forestiero: quassù il quadro si vende, ma deve essere questo e non altro!”. Il quadro, in altri termini, dev’essere una rapida dilettazione bottegaia da esaudire il capriccio del viaggiatore distratto e poter comodamente trovar posto in valigia. Quanto a questo secondo punto, anche Rimini ha finito coll’adattarsi: ha costretto, ha limitato la mole spaziosa e prediletta dei propri lavori, riservandosi una ripresa del proprio gusto e delle proprie preferenze a tempo opportuno; ma quanto al primo punto egli si è rifiutato, in modo deciso. Egli non farà mai del dilettantismo o del mercantilismo, nemmeno per arricchire».
Riassumendo: all’indomani dell’importante riconoscimento ricevuto con la personale in Palazzo comunale del 1927, Rimini si allontana da Catania. I motivi sono essenzialmente due: la ricerca di un mercato più dinamico – che però pone dei problemi di esigenze precise di commerciabilità –, il senso di straniamento che il fattore di opere concrete prova di fronte ai rampanti e vocianti artisti delle nuove generazioni: il taciturno Rimini scuote il capo davanti agli astratti quesiti di Cardile e da artista-artigiano si pone ben più concreti problemi di confronto con la natura. Non nascondo che, accanto a questi dati di fatto testimoniati da Cardile, si intravvede anche dell’altro, ma si tratta di sensazioni sfuggenti e non è il caso di indulgervi. Certo, la situazione artistica del capoluogo etneo vede l’affermarsi alla fine degli anni Venti di più giovani e agguerriti artisti. Su tutti, spicca M.M. Lazzaro che quasi di vent’anni più giovane di Rimini, era nato nel 1905, reduce dall’esperienza all’Accademia di belle arti di Roma e forte dell’amicizia dei romani Scipione e Mafai, si sta velocemente affermando come infaticabile e irriverente animatore artistico catanese.
Cosa avrà pensato Rimini leggendo sul primo numero, maggio 1928, di «Fondaco»: «Dio, Signore della Terra, del Cielo e del Mare noi ti preghiamo perché possano crepare presto: … Vincenzo Gemito … Ettore Tito … Antonio Mancini … Ugo Ojetti, F.T. Marinetti»? Non è difficile cogliere nella Preghiera di Lazzaro, oltre il gusto per lo sberleffo di radice futurista, ben altre prepotenze che si vanno velocemente affermando nella società italiana. Il Marinetti opportunista di questa sua ultima fase – valga per tutte la nomina ad Accademico d’Italia nel 1929 dopo le tante battaglie futuriste contro ogni Accademia – non farà fatica nello stesso 1928, in dicembre, a far visita a Catania allo studio di Lazzaro e ad interessarsi alle sue opere, a dispetto delle maledizioni ricevute pochi mesi prima. Il gesto però è chiara testimonianza del prestigio che il giovane catanese sta velocemente raggiungendo a livello anche extra-locale: nel 1929 sarà lui ad essere investito della carica di Fiduciario del Sindacato locale.
È stato acutamente sottolineato che sul punto specifico della produzione artistica il fascismo non ha avuto programmi condizionanti. Non a caso lo stesso Mussolini, inaugurando la «Prima mostra del Novecento» nel 1926 al Palazzo della Permanente di Milano, si limita ad insistere su alcuni elementi caratteristici comuni estremamente generici: «la decisione e la precisione del segno, la nitidezza e ricchezza di colore, la solida plasticità delle cose e delle figure». E tuttavia, per quanto generici, non sfuggirà che rispetto alle opere fin ora esaminate di Rimini siamo agli antipodi. Anche nel caso di dipinti come Aratura del 1925 o La trebbia del 1928 (tavv. XIV-XV), temi pur apparentemente alla moda in anni di riforma agraria, bonifiche e «battaglia del grano», le scelte formali di Rimini sono tutte nella direzione di una antimonumentale, non ostante i grandi formati, rappresentazione della natura e del lavoro dei campi: le pennellate si caratterizzano per le lunghe striature o i brevi tocchi, e se in Aratura le figure, sia umane che animali, tendono addirittura a fare cromaticamente tutt’uno con il paesaggio, anche in La trebbia, per quanto maggiormente messe in evidenza, non sono eroicizzate.
Ma prima di addentrarsi nell’analisi del rapporto fra la pittura di Rimini e la cultura dei cosiddetti «anni difficili», come è stata intitolata una recente mostra sull’arte a Napoli dal 1920 al 1945, è bene provare a sciogliere un altro nodo critico ricorrente nelle parole di chi si è esercitato sui dipinti di Roberto Rimini: il rapporto fra questi e la corrente letteraria del Verismo, la sua presunta «scelta verghiana». Una semplice scorsa al catalogo delle opere mostrerà l’insistenza dell’artista nella scelta di temi legati al mondo del lavoro dei campi e, ma solo dal secondo dopoguerra inoltrato, dei pescatori. Senza ripetere quanto già detto in avvio e pur accettando di limitarsi, per ora, solo all’aspetto iconografico, è tuttavia evidente che Rimini dà una rappresentazione vera del lavoro umano ben distante da quella del «“galantuomo” Verga [che] gestisce i suoi esperimenti in vitro con ineccepibile obbiettività positivistica, un’obbiettività talmente geniale da farsi prendere (oggi) per carità», per dirlo con le parole di Gianfranco Contini. Semmai in Rimini sembra, nella maggior parte dei casi, di percepire una commossa partecipazione nel tentativo di rendere la parca gestualità, i dialoghi sommessi, la serenità del riposo, l’allegria contenuta della festa del mondo degli uomini, non dei «vinti». Per quanto evidentemente formatosi nel culto dei Capuana, Verga e De Roberto, Rimini, non mettendo alcun diaframma fra sé e il mondo che osserva, ci offre una folla anonima, non a caso spesso vista da tergo, di lavoratori, cui si accosta silente per testimoniarla, senza eroicizzarla né giudicarla, né tanto meno prefiggersi l’obiettivo di allestirne una tassonomia. Vellicando, semmai, il suo pubblico borghese con la messa in scena di quelle attività popolari nelle quali ritrovare le proprie radici sociologicamente, ma non cronologicamente, distanti, come ben descritto nel saggio che ci precede da Giuseppe Giarrizzo.
Questo tipo di chiave di lettura sembrerebbe, tuttavia, non poter essere esteso anche all’analisi di opere di non molto successive come la monumentale Trebbiatura del 1933 o Mietitura, quest’ultima però in serie con Scarto dei limoni e Vendemmiatrici, del 1940-1941 (tavv. XIX; XLIV-XLV; fig. 83). Ad un primo sguardo già in Trebbiatura è evidente che le preoccupazioni di ortodossia iconografica hanno prevalso e condizionato lo stesso linguaggio formale. Basterebbe considerare il dettaglio a destra, la madre che si china a baciare la bambina, per cogliere anche il disagio formale ad inserire un’incongrua, per il contesto, allusione ai valori della famiglia. Per quanto l’operazione della trebbiatura sia ancora, con l’arcaicità della tradizione, affidata al gesto degli uomini e degli animali, traspare una meccanizzazione. Si colgono facilmente le gerarchie fra gli uomini, e fra questi e gli animali: il tutto è, dev’essere, ‘ben’ disegnato, ‘ben’ disposto; il colore è sottomesso alla chiarezza dell’enunciato; le forme acquistano solidità plastica. Ma ciò, evidentemente, va a scapito della freschezza dell’opera che prende il ritmo e le semplificazioni del manifesto pubblicitario: valga, per tutti, l’esempio dei forconi che, sulla sinistra, hanno le superfici lisce e regolari dell’artificiale, della plastica, e non le asperità e le imperfezioni del naturale, del legno; o, ancora, si confronti il giogo, con i nodi del legno ordinatamente disposti, con quello della Trebbia del 1928 che, nel diverso assorbire la luce, mostra le sue irregolari scheggiature, le sue imperfezioni, tanto da essere stato rinforzato là dove il cavo si tende. Sette anni dopo, nel ciclo dei Lavori dei campi, l’effetto propagandistico sarà ulteriormente esasperato dall’adozione di una tecnica quasi bicroma, dalla scomparsa del colore: al grigio del disegno e all’azzurro del cielo si accompagnerà, in ciascuno dei pannelli, il giallo del grano, l’arancio degli agrumi, l’ambra vinaccia dei grappoli d’uva.
Non è difficile cogliere in questa fase della pittura di Rimini la necessità dell’accedere a coloro che detengono le leve del potere e, con esse, decidono delle commissioni pubbliche. E tuttavia, gli si farebbe torto se non si prestasse attenzione anche alle opere che in questi stessi anni Trenta andava producendo per il mercato. Perché è in questa dimensione che, accanto a più immediate rappresentazioni di temi del lavoro, a robusti e intensamente naturalistici ritratti, ad una serie di paesaggi – nei quali talvolta emerge il rischio di concessioni all’oleografia –, si possono trovare un insieme di nature morte e di dipinti all’aperto che ci mostrano come la luce, il colore, siano il vero leit-motiv, la vera competizione artistica di Rimini. Ci si provi a ricomporre una sequenza formata dalle due versioni di Estate a Milo (tav. XXX; fig.64) e da Terrazza assolata (tav. XXXI), tutti del 1938, da Crisantemi gialli del 1934 e da Fiori-Armonia e Vaso con ginestre, entrambi all’incirca del 1940 (tavv. XXIV; XLVI-XLVII). Si può partire proprio da questi ultimi due che, realizzati con morbidi pastelli, ben rappresentano la gioia del colore, la ricerca della forma non come stolida solidità ma come luce costruita e se piano e fondo si confondono nel primo, nel secondo la confusione non può esserci perché stavolta la sfida è nel controluce, nell’illuminare ciò che è in ombra. Si potrebbe eccepire che molti di questi effetti sono propri del pastello ma, a parte che nella scelta dei mezzi è la sapienza dell’artista-artigiano, non è difficile riconoscere nella brocca con le ginestre la gemella di quella eletta a protagonista delle due versioni di Estate a Milo. E qui, sia nella versione drammatica col tavolo dalla cornice guasta e dal tono più basso, sia in quella più accomodata dai toni squillanti, è il pennello forzato ad ammorbidirsi: si veda la vertigine dell’impasto che, nella prima versione, liquefa le forme sulla destra sotto l’albero, in questo caso spoglio di frutta. Né su lunghezze d’onda distanti erano stati concepiti i Crisantemi gialli, fuochi d’artificio bianco-gialli, raccolti in un vaso poggiante su di un tavolo inerpicatissimo – a sua volta coperto da una tovaglia così rapidamente allestita da dare la sensazione che il ricamo a filet dell’orlo sia fatto di strappi – e stagliantisi su un fondo, una parete, che fa tutt’uno cromaticamente col pavimento.
Torna utile a questo punto sottolineare che i tanti ‘fiori’ che si incontrano nell’opera di Rimini non devono essere confusi con prove di facile occasione decorativa, prodotti di minore impegno facilmente commerciabili, anonimi e sempre buoni complementi d’arredo del salotto borghese. Possono essere tutto questo, e a volte lo sono, ma non lo sono in sé. In realtà, Rimini mostra di sapere bene che «i fiori di stagione sono pretesti più che sufficienti per esprimersi ‘in forma’», per usare la terminologia di Longhi, vocaboli necessari e «sufficienti ad evitare le secche dell’astrattismo», dal quale peraltro è, evidentemente, ideologicamente lontano. Ma non è lontano dalla ricerca della qualità pittorica che, sa bene, non è ricerca di generiche bellezze, di corretti enunciati, di contenuti ‘alti’, ma risposte visive a quesiti formali.
In questo senso anche la tecnica bicroma può essere utilmente adottata: una volta fuori dalle strettoie condizionanti della ufficialità, possono prendere vita due capi d’opera come lo Scarto dei limoni e il Carico d’arance del 1939 (tavv. XLII-XLIII), dove la limitazione cromatica è sfruttata per sperimentare la possibilità di rendere in grande dimensione la luce attraverso l’addensarsi e il rarefarsi del tratto e dove di nuovo la presenza umana è trattata con lo stesso valore delle cose: senza alcuna eroicizzazione. Del resto le stesse maglie dell’ufficialità dovettero essere piuttosto larghe se acconsentirono alla realizzazione dei due murali per la Casa del mutilato, Sull’argine e In marcia del 1939 (figg. 66-67), che il reduce della grande guerra Rimini svolge, attingendo forse a propri ricordi, con evidenti punte di antieroica rappresentazione nei corpi stanchi, affaticati, piegati di soldati silenziosi.
La cesura della seconda guerra mondiale non ha riflessi immediati nella produzione artistica di Rimini che nel 1949 è invitato a partecipare alla «Mostra d’arte contemporanea (40 anni d’arte italiana). Mostra degli artisti siciliani», tenutasi tra il febbraio e l’aprile del 1949 a Catania e Palermo «sotto gli auspici e con l’organizzazione tecnica della Biennale di Venezia». È interessante notare che nel 1948 si era tenuta la XXIV Biennale, la prima postbellica, passata alla storia come la «più grande manifestazione di arte contemporanea mai allestita». Per quell’occasione Longhi aveva proposto e ottenuto una grande mostra dedicata agli impressionisti – «come primo atto di contrizione e ricognizione di fronte alla cultura figurativa moderna da cui c’eravamo stolidamente estromessi» – e Francesco Arcangeli, preavvertendone gli sviluppi, avrebbe commentato: «sentiamo che l’impressionismo non è una conclusione; ma è una finestra spalancata su di una nuova dimensione umana». Nel mentre si andavano polarizzando le polemiche fra astrattisti e realisti e il dibattito sembrava postulare una scelta «fra un termine non vitale come è l’astrattismo puro, un termine ancora equivocamente formulato come è quello del realismo», la punta più specificamente attrezzata della critica additava agli artisti quella pittura di valori formali, di luce, di natura en plein air nella quale anche la ricerca di Roberto Rimini poteva trovare conforto. Continuando nella sua opera, riprendendo anzi interessi per immediatezze di visione, può sentirsi ancora attuale quando, apparentemente, il nuovo è l’astratto e il figurativo ha da essere espressionisticamente impegnato. Può dimenticare in fretta pletorici plasticismi a cui pure si era dovuto adattare e far intridere di luce e di colore vestiti e foglie, visi e barche. Ed infatti, nei suoi oli degli anni Cinquanta il colore riprende libero a squillare, le pennellate conoscono un nuovo nervosismo e una nuova corposità, indipendentemente dai soggetti trattati.
Un altro trasferimento caratterizza l’ultima fase della biografia artistica di Rimini: nel 1952 si stabilisce ad Aci Trezza: il piccolo paese di pescatori immortalato nei Malavoglia di Verga; lo stesso paese che cinque anni prima, nel 1947, aveva fornito l’ambientazione e partecipato coralmente a La terra trema di Luchino Visconti, film che, inizialmente concepito come prima parte di un trittico di documentari commissionati dal Partito comunista italiano, sarebbe poi stato premiato nel 1948 alla Biennale di Venezia. Il tema dei lavoratori del mare, dei pescatori, si afferma nella produzione di Rimini. Poiché il pittore dipinge ciò che vede, non dà corpo a fantasmi, e neanche reinventa la realtà, non è necessario: perché ci si dovrebbe ergere arrogantemente a creatori quando è già tanto laborioso rappresentare sulla tela ciò che si vede?
Ecco allora – in Piazza di Acitrezza del 1952 e in Chiarità del 1953 (tavv. LXVIII-LXIX) – che sul palcoscenico si affollano nuovi attori: chiusa dalla cortina di anonime case silenziosamente abitate la piazza è affollata dal riposo delle barche ricoverate. Più tardi, quando il sole si abbasserà, basterà fare quattro passi, allontanarsi un po’, in questo pomeriggio invernale, per allargare lo sguardo, per accorgersi che quella folla di barche è solo una macchia di colore più intenso, poche linee di colore azzurro-blu al centro. Ed anche quando il tema sarà quello del lavoro dei campi – Schiene a terra del 1954 (tav. LXXVIII) – un faraglione potrà fare capolino sullo sfondo, incorniciato dal fusto e dalle foglie più basse di un albero. Così in Ricamatrici – Artigianato familiare del 1954-1955 (tav. LXXVI) sullo sfondo troverà posto ancora il mare e la costa verso Acicastello. Quattro dipinti di tema e di impegno diverso, con diversa destinazione e intenzione comunicativa, ma tutti declinazione di uno stesso linguaggio pittorico che è quello di una serena, solare, quotidianità. E le varianti, pure evidenti, non sono più forzature alla propria indole, tentativi di adeguamento a richieste poco comprensibili, ma recupero di quella sapienza artigiana per la quale non esiste ‘il’ modo, ‘la’ tecnica, ‘la’ poetica, bensì un bagaglio di esperienze alle quali attingere per ottenere il miglior risultato possibile. Se, come in Ricamatrici, chiarezza di forme hanno da essere, lo saranno, e si potrà anche prendere qualche misura, si potrà anche fare qualche calcolo, acché tutto risulti decorosamente ponderato, ma i vestiti, anche i semplici fazzoletti sul capo, continueranno a crocchiare di luce e i colori giammai saranno quelli dei panni rasati, né gli oggetti – le sedie impagliate, il tombolo, i vasi di gerani – saranno accomodati, leccati, ornati.
Arrivato all’ultimo decennio di attività, e di vita, Rimini è ancora capace di allestire veri capi d’opera e soprattutto di procedere innanzi, e sempre più liberamente, nella sua ormai decennale ricerca della luce. Un gruppo di opere, come Masseria (tav. LXXXI) e una prima versione di Trasporto delle reti del 1960 ca. (tav. XC), Vendemmiatrici (tav. LXXXVI), Fatica (tav. XCV), Merenda all’aperto del 1964-1965 (tav. LXXXVIII), Il carico delle arance del 1967 ca. (tav. LXXXVII), A secco, Mietitura, e Campo di grano del 1968-1969 (tavv. XCI-XCIII), segnano queste ultime tappe. Basterà soffermarsi su Fatica per coglierne immediatamente la matericità, la volontà di pittura pura che si incatena alla figura per non correre il rischio del cerebralismo, dell’astrazione. Il pennello intriso di colore non lo stende ma lascia che vere e proprie colature coprano la tela che, bianca, partecipa a pieno titolo all’insieme. Quando questa si fa spazio fra i densi grumi lasciati dal pennello, anche il diverso spessore agisce sul nostro occhio: ombre bassissime abbassano il tono e il bianco che emerge è attutito; perché per la camicia si deve usare il pigmento e al bianco si deve mescolare il grigio. Basta poi provarsi ad isolare il rettangolo fra i due fusti paralleli della gamba in primo piano e dell’albero per scorgere il compiacimento per il colore, la dissoluzione delle forme.
Anche i paesaggi, perché questo sono a dispetto dei titoli, di Mietitura e Campo di grano tendono ad un superamento delle forme naturali. E se nel primo ancora l’alta linea dell’orizzonte e la quinta del cipresso sulla destra impongono una più immediata e riposante riconoscibilità, nel secondo solo la presenza di abbozzate figurette trattiene l’occhio dal seguire astratte partizioni dello spazio della tela: tre sezioni cromatiche che non cercano profondità, progressioni prospettiche, ma si giustappongono sullo stesso piano.
Sono passati sessant’anni dai primi dipinti di cui abbiamo traccia – Caldarroste del 1906-1908, Campagna a Vasadonna del 1907 ca. (figg. 1; 9), un paio di ritratti coevi – Roberto Rimini, con il suo quotidiano impegno, ha percorso ettari di tela, di tavola, di carta, cercando di catturare la luce, di rinnovare il laicissimo miracolo della pittura che, come orgogliosamente aveva affermato e individuato fra gli altri Leonardo, «porta per tutto con seco lume e ombra». Il percorso artistico di Rimini si è snodato lungo un ampio tratto del XX secolo, il «secolo breve» caratterizzato in arte dalle avanguardie, e dalla loro morte e rinascita; dal proliferare degli ‘ismi’; dall’aggrupparsi degli artisti in correnti, gruppi, tendenze; dal moltiplicarsi di manifesti, proclami, lettere d’intenti – una produzione, in certi casi, maggiore in confronto alle stesse opere. A tutto questo, apparentemente, Rimini è rimasto estraneo, defilato, appartato: artigianalmente dedito alla fattura di dipinti, disegni, litografie che naturalisticamente fermassero il tempo e dessero pezza d’appoggio al ricordo. Solitario, schivo, laconico così ci viene ricordato e così le sue opere ce lo presentano. E tuttavia la sua scelta coerente non è frutto di marginalità subite ma consapevole rifiuto delle avventure. Dal suo angolo di Sicilia Rimini sembra osservare e soppesare le novità che altrove si vanno affermando e le può anche, a volte, sperimentare ma sempre addomesticandole, nella coscienza che, al di là dello Stretto, di importante sarà diversa sopra tutto la luce, e poco altro.
Un quadro di fiori, Rose del 1970 (tav. C), un delicato omaggio resistente nel tempo, può ben prestarsi a concludere queste pagine. Non si troverà in esso alcuna linea di disegno, anche gli steli, troppo dritti ormai, soggiaceranno alle macchie delle foglie e dei petali inumiditi dalla rugiada della luce.